\\ Home Page : Pubblicazioni
Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
Articoli del 16/06/2011
I suoli che corrono lungo la spiaggia di Castellammare, dal largo Quartuccio fino al fiume Sarno, fanno parte da sempre del demanio pubblico e, in virtù di tale natura, sono stati censiti a diversi cittadini dietro il versamento di un canone. Il 12 marzo 1793, su disposizione reale, due ingegneri, il napoletano Ignazio de Nardo e lo stabiese Catello Trojano, ne elaborano la relativa pianta, finalizzata ad una censuazione più consona alle nuove esigenze, susseguente alla loro divisione in varie sezioni. Proprio all’inizio del largo Quartuccio il Comune fa costruire due fabbricati, uno per la casa comunale, l’altro per i magazzini del grano che, negli anni 1829 e 1831, sono venduti a Giovanni Rispoli e Antonino Spagnuolo. Le altre porzioni terriere vedono come censuari, nell’ultimo decennio del Settecento, Vincenzo Cosenza, Michele Stanzione, Vincenzo Gonziano, Nicola Amato e Vincenzo Scelzo, surrogati, rispettivamente, nell’arco del primo trentennio dell’Ottocento, da Fortunato e Michele Palumbo, Antonio Mereghini, marchese de Turris, Catello Spagnuolo ed altri i quali, secondo le proprie necessità e possibilità, vi edificano varie costruzioni senza alcuna licenza. A fronte di tali modifiche d’uso viene intimato ai responsabili la restituzione del suolo che dà adito ad un aspro contenzioso, conclusosi, l’11 marzo 1842, con la sentenza della terza camera del tribunale civile di Napoli, secondo cui l’azione intrapresa è ormai estinta per perenzione. Nel frattempo l’intera area è stata dotata delle debite infrastrutture viarie. Infatti, risale al 1834 la costruzione della strada pubblica lungo le suddette costruzioni dal largo Quartuccio alla fabbrica dei cuoi, nelle cui prossimità si eleva il cantiere mercantile. Un’altra strada, costruita l’anno precedente “con basolata” e, successivamente, ricoperta di brecciame, giunge fino al torrente San Marco, arginato con forti mura e ornato di un ponte, che favorisce la comunicazione tra le sponde opposte. La distesa arenosa di questa zona fino alla foce del fiume Sarno cade sotto il rescritto reale di agosto 1844 che ne ordina la censuazione al fine di favorirne la coltura. Una parte del suolo dal fiume Sarno fino al Camposanto viene occupata dalla strada ferrata, un’altra parte è assegnata ai fratelli Spagnuolo e agli eredi di Taddeo Vernacore per la ricostruzione delle “caldaie” in compenso dei quelle demolite nel cantiere reale. Vi è sottesa l’intenzione di collegare anche queste parti dell’opportuna rete viaria come ramificazione ulteriore di quanto realizzato prima. Anzi nello specifico vige il rispetto assoluto di alcune regole basilari, facenti parte di un piano di costruzione di massima e rientranti nell’utilità della collettiva stabiese, soprattutto, per quanto concerne la riserva di determinati spazi: così quelli nei pressi del surriferito torrente hanno la funzione di permettere l’accesso dalle paludi agli abitanti della frazione di Schito; quelli prospicienti alla marina mirano a consentire il “bordeggio” del mare, il tiro delle reti da parte dei pescatori e il rimorchio delle barche da pesca; quelli lungo il molo e innanzi al forte sono destinati alla costruzione di qualche chiesa. Il contenuto costituisce il nerbo della memoria scritta, il 24 agosto 1845, dal sindaco Antonio Vitelli per il controllore distrettuale delle contribuzioni Carlo Gargiulo.
La necessità di riparare l’ormeggio delle barche nel periodo delle avverse condizioni atmosferiche spinge l’amministrazione comunale di Massa Lubrense a deliberare di costruire nelle immediate prospicienze della sua costa marina, contrassegnate da due grandi massi calcarei già esistenti, una scogliera, sulla cui base è in animo di edificare successivamente una banchina. Il relativo progetto, presentato dall’architetto Camillo Ranieri il 3 agosto 1842, contempla l’esborso di 3862 ducati e quaranta grana. Risultano aggiudicatari della gara pubblica gli imprenditori edili Vincenzo Buonocunto e Ferdinando Scelzo i quali ne sottoscrivono le condizioni dello strumento notarile il 23 agosto 1842, allorché si impegnano ad eseguirne i lavori ad opera d’arte in cambio di pagamenti, comprensivi dell’interesse del cinque per cento a scalare e scanditi progressivamente nell’immediato futuro fino alla chiusura definitiva del cantiere. L’attività lavorativa, iniziata nel 1° settembre 1842 sotto la direzione del suddetto tecnico e di due decurioni Mattia Turris e Giovanni Persico, procede con una certa lena. Infatti, dopo un anno è già stata terminato il primo tratto e versa in uno stato avanzato il secondo tratto, tanto che l’Intendente della provincia di Napoli ordina al tecnico la misura di quanto effettivamente compiuto. La risposta arriva con calma assoluta il 10 giugno 1844, allorché la quantificazione parziale delle spese ascende a 2874 ducati e quarantotto grana. Di lì a poco, terminata l’intera struttura, avviene la rendicontazione totale pari a 7691 ducati e venti grana, maggiorata di 3872 ducati e otto grana rispetto al preventivo. Nel periodo interino dell’iter procedurale per la liquidazione, precisamente nel gennaio 1845, il secondo tratto della scogliera viene abbattuto dall’impeto violento delle onde e disperso nel fondo del mare. A questo punto il sindaco convoca subito il decurionato, invitandolo ad esprimersi sulla eccedenza della spesa presentata e sul danno testé avvenuto. La delibera finale, varata all’unanimità dei presenti, respinge la misura finale dei lavori avanzata, delegando l’architetto Celentano non solo a controllarne la rispondenza e la congruenza di quanto rivendicato, ma anche ad additare le cause dell’abbattimento. Di lì a poco, il 10 febbraio 1845 giunge la perizia giurata del tecnico di parte: costui contesta senza mezzi termini l’eccedenza della richiesta e imputa agli imprenditori edili la colpa “di non aver nettato e espurgato il fondo del mare” , ove si addensano le cause fondamentali del crollo: la scogliera risulta priva di “scarpe necessarie”, né eseguita “a strati paralleli”; inoltre gli scogli non allocati su “sponde di grandezza sufficiente”. Tale rapporto, fatto proprio dal decurionato, viene inviato all’Intendente della provincia. A questo punto scatta l’indagine superiore con l’invio in loco, il 15 marzo 1845, dell’architetto Ercole Lauria. Costui ritiene, nella relazione datata 30 agosto 1845, che la causa del crollo della scogliera consista nella sua errata inclinazione, non rispondente ai calcoli progettuali. Su queste basi, contestate dalla controparte, si spalancano le porte del contenzioso che, bruciando notevoli energie finanziarie, non concede sconti nemmeno lungo l’asse temporale
Fotografie del 16/06/2011
Nessuna fotografia trovata.
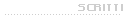
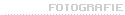

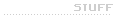
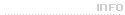
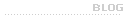
 Feed RSS 0.91
Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3
Feed Atom 0.3 (p)Link
(p)Link Commenti
Commenti Storico
Storico Stampa
Stampa